Quando sei triste: 3 cose che aiutano davvero (e 3 che peggiorano tutto)
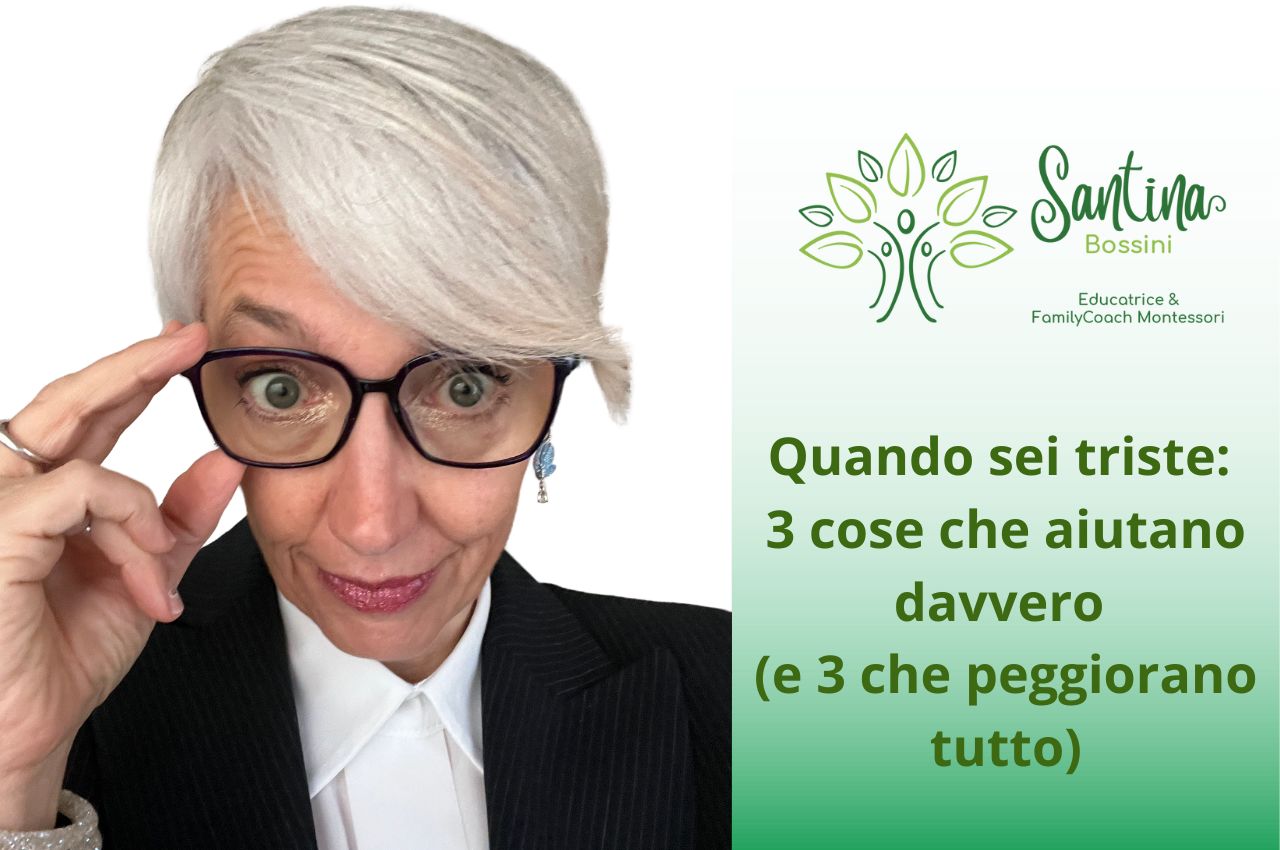
Quando sei triste: 3 cose che aiutano davvero (e 3 che peggiorano tutto)
Ci sono giorni in cui la tristezza entra in casa senza bussare.
Non sempre ha un motivo chiaro, non sempre si presenta con una scena drammatica. A volte è semplicemente una "nebbia" sulle cose: ti muovi, fai, rispondi… ma dentro senti che qualcosa è più lento, più pesante, più opaco.
E qui spesso scatta l’equivoco più comune: pensare che allenare la felicità significhi evitare la tristezza.
Io la vedo diversamente: non si può evitare la tristezza.
Allenare la felicità significa imparare una competenza di vita: restare presenti quando arrivano emozioni che non abbiamo scelto, e trasformare quel momento in un’occasione di ascolto e di direzione.
La tristezza è “l’altra faccia della medaglia” non perché sia il contrario della felicità, ma perché è una delle emozioni che ci ricordano che siamo umani, vulnerabili, attraversati da bisogni spesso ignorati e da aspettative sociali che non ci appartengono.
E se è vero che felici s’impara, è anche vero che si impara proprio lì: nel modo in cui stiamo dentro alle giornate storte, ed è complicato, e qualche volta anche tanto complicato.
La tristezza: non una nemica, ma un segnale (senza romanticismo)
Nella prospettiva del coaching umanistico e spirituale, io non parto dall’idea che le emozioni siano “problemi” da risolvere in fretta: le considero un linguaggio. Un modo con cui la vita interna prova a farsi capire prima ancora che noi abbiamo le parole giuste.
E qui vale una distinzione che chiarisce molto: emozioni e sentimenti non sono la stessa cosa.
Le emozioni sono risposte rapide e spesso corporee (un’onda): arrivano, attivano il corpo, orientano l’attenzione. Sono più immediate che razionali.
I sentimenti sono l’emozione “letta” e rielaborata dalla mente nel tempo: diventano una trama più stabile, fatta di pensieri, significati, memoria, interpretazioni e valori. In pratica: l’emozione è il segnale; il sentimento è il modo in cui quel segnale viene abitato e raccontato.
Per esempio: la tristezza come emozione può essere un impulso breve (una stretta al petto, un groppo in gola, un calo di energia). Se però a quella tristezza si agganciano frasi interiori ripetute (“non ce la farò”, “sono sola”, “non valgo”), allora può trasformarsi in un sentimento più duraturo: scoraggiamento, malinconia, amarezza, sfiducia.
Questa distinzione è importante tenerla ben presente perché ci fa vedere dove possiamo lavorare: non sempre possiamo impedire l’emozione, ma possiamo intervenire su ciò che ci costruiamo sopra (il racconto, le conclusioni, le scelte).
E allora la tristezza, come emozione, spesso segnala:
una perdita (non solo lutti: anche perdite apparentemente minori, delusioni, aspettative cadute)
un distacco (da una persona, da un progetto, da un’immagine di sé)
un bisogno rimandato troppo a lungo
un carico emotivo che stiamo portando da soli
un confine che non abbiamo saputo proteggere
Non sempre la tristezza ha un significato nitido e immediato: a volte si tratta di stanchezza, di stress accumulato, di un “troppo” che il corpo registra prima della mente.
Ma una cosa sì: la tristezza, quasi sempre, ci chiede rallentamento e ascolto.
Ed è qui che entra in gioco anche un principio Montessori (che vale benissimo per gli adulti): quando l’ambiente è sovraccarico, confuso, troppo pieno di stimoli e richieste, l’organismo tende a chiudersi. Per ritrovare equilibrio spesso non serve “spingere di più”, ma preparare un ambiente (interno ed esterno) che sostenga.
E qui mi torna in mente una frase attribuita ad Antoine de Saint‑Exupéry: “La perfezione si raggiunge non quando non c’è più niente da aggiungere, ma quando non vi è più niente da togliere.”
Impariamo ad alleggerire, alleggerire il nostro ambiente interno e anche quello esterno.
Un confine necessario: quando non basta “gestirla da soli”
Diciamolo senza giri: a volte la tristezza è un’onda che chiede ascolto. Altre volte è un segnale che chiede un aiuto più strutturato.
Il criterio che, più di tutti, fa chiarezza è il tempo. Ma non solo in senso numerico.
Una tristezza “normale” (per quanto scomoda) tende ad avere un andamento ondoso: arriva, sale, ti attraversa e poi lascia spazio a aperture. Non significa “stare bene”, significa che ogni tanto torna respiro: ti capita di concentrarti, di appoggiarti a qualcosa di semplice, di sentire che non sei solo quel nodo.
Quando invece la tristezza diventa un clima costante, il tempo cambia qualità: non è più qualcosa che va e viene, è una presenza che occupa le giornate e restringe lo spazio interno. Qui la domanda non è solo “da quanto dura”, ma come sta durando:
Ci sono (o no) finestre di sollievo?
Resta legata a momenti specifici o si allarga a tutto?
Ti lascia ancora la possibilità di fare un gesto di cura o spegne quasi ogni iniziativa?
Nel viaggio di conoscenza della tristezza questo passaggio è centrale: non giudichiamo l’emozione, ma osserviamo i suoi indicatori (intensità, frequenza, durata, impatto). È un’osservazione molto “Montessori per adulti”: guardare la realtà così com’è, senza etichette e senza drammatizzare, per capire quale percorso serve davvero.
E anche qui la CNV aiuta: invece di dirci “non dovrei stare così”, possiamo chiederci con onestà: che cosa sta succedendo nel mio quotidiano, da quanto, e quanto mi sta limitando?
Se la tristezza:
dura molte settimane senza aperture,
ti spegne quasi del tutto il piacere (anche delle cose che amavi),
ti blocca nel quotidiano delle tue giornate (cura di te, lavoro, relazioni),
si accompagna a autosvalutazione pesante,
o a pensieri di farti del male,
la scelta più matura è parlarne con un professionista della salute mentale (psicologo/psicoterapeuta/medico).
Qui è utile chiarire, con delicatezza ma con precisione, la differenza tra psicologia/psicoterapia e coaching.
La psicologia clinica (e la psicoterapia) si occupa di valutare e trattare la sofferenza psicologica quando diventa un disturbo, un blocco significativo o un rischio per la salute. Può fare una valutazione, lavorare su sintomi e cause, usare strumenti e metodi terapeutici, e — quando serve — integrarsi con il medico.
Il coaching non fa diagnosi e non tratta patologie: è un percorso di allenamento e sviluppo orientato a obiettivi, risorse, consapevolezza e azione. Lavora sul presente e sul futuro, sul modo in cui ti muovi nella vita, sulle scelte, sui punti di forza e sulle strategie per attraversare i momenti difficili senza perderti.
In pratica: quando la tristezza è intensa, persistente e ti spegne, la cornice clinica è spesso la più adeguata. Il coaching può comunque essere un sostegno prezioso in parallelo (o in una fase successiva), per ricostruire direzione, abitudini di cura, fiducia e passi concreti.
Questa non è “allarmismo”: è cura della realtà.
La tristezza ha sempre un motivo (anche quando non lo vedi)
Sì: anche quando ti sembra “senza motivo”, la tristezza un motivo ce l’ha. Solo che non sempre è immediato, non sempre è razionale, e spesso non è un evento unico e chiaro.
A volte il motivo è una perdita che hai minimizzato. A volte è un bisogno rimandato. A volte è un sovraccarico che hai normalizzato. A volte è un confine che non stai proteggendo. A volte è un tempo di vita che chiede di cambiare ritmo.
Quindi non è che la tristezza arrivi dal nulla: arriva quando qualcosa dentro di te sta dicendo “così non ce la faccio più come prima”.
E poi c’è una cosa ancora più vera: quando vivi una relazione di cura (e questo, spesso, significa essere mamma), la tristezza raramente si presenta come una cosa “tua e basta”.
Arriva mentre stai facendo altro. Arriva mentre qualcuno ti chiama. Arriva mentre devi comunque essere presente, e magari anche gentile.
E allora succede questo: ti dici che non puoi permettertela, la metti da parte, stringi i denti… e poi, a fine giornata, ti ritrovi più vuota.
Qui non ti propongo un elenco infinito. Ti propongo tre scelte che, quando sei triste, fanno davvero la differenza. Scelte concrete, realistiche, ripetibili. Scelte da vita quotidiana e concreta.
3 cose che aiutano davvero quando sei triste
1) Radicamento: tornare al corpo per sentirti sostenuta
Quando sei triste, la mente vuole spiegazioni. Il corpo, invece, chiede una cosa più semplice: sostegno.
E il sostegno comincia da qui: tornare al presente. Non serve il bosco. Non serve “fare bene”. Basta un minuto ovunque tu sia.
Radicamento rapido (60–90 secondi, ovunque):
Piedi: senti i piedi. Premi leggermente a terra.
Contatto: nota tre appoggi (piedi, schiena, mani…).
Sguardo: trova 5 cose che vedi e nominale mentalmente.
Respiro: espira un po’ più lungo per 5 volte.
Frase di presenza: “Sento la mia tristezza e la accolgo.”
Questo non “risolve” la tristezza. Ma spesso fa una cosa fondamentale: la rende sostenibile.
Ti suggerisco un nuovo approccio, ispirato anche al LoveHealing (la pratica di guarigione interiore che ho studiato con Lucia Merico nel percorso di formazione come Spiritual Coach®): affidare con amore ciò che stai vivendo — non come rinuncia, ma come atto di fiducia consapevole nella guarigione e speranza nel futuro.
In concreto: porti la situazione nel cuore, formuli un intento chiaro (cosa desideri guarire o comprendere), dai una direzione (il passo che scegli di fare), e poi la affidi all’Universo con la certezza interiore di ricevere guida e sostegno nel processo.
E mentre affidi, resti con i piedi per terra: respiri, ti radichi, e fai il tuo passo possibile — perché spiritualità e responsabilità, qui, camminano insieme.
2) Preparare l’ambiente: Montessori per adulti (e sopratutto per le mamme)
Quando sei triste, spesso non hai bisogno di “motivarti”. Hai bisogno di ridurre il troppo.
È un principio Montessori che vale anche per noi grandi: quando l’ambiente è sovraccarico, il sistema si chiude. E allora la cura può essere sorprendentemente concreta.
Scegli una sola azione essenziale che rimetta ordine e ossigeno:
aprire la finestra e cambiare aria
bere un bicchiere d’acqua e sederti 30 secondi
doccia tiepida (anche veloce)
riordinare un angolo (uno)
Non è “positività”. È igiene emotiva. È dire al tuo corpo: qui c’è spazio per me, anche oggi.
3) Dire cosa ti serve (senza sentirti egoista): CNV in versione mamma
Molte mamme soffrono in silenzio perché pensano che chiedere sia un peso. E così diventano brave a resistere… ma non a farsi sentire e sostenere.
La CNV, nella sua essenza, è questo: trasformare un nodo in una richiesta pulita.
Formula breve:
“In questo momento mi sento… (triste / fragile / stanca).”
“Ho bisogno di… (silenzio / vicinanza / 10 minuti da sola / un abbraccio).”
“Puoi… (occuparti tu di… / ascoltarmi senza consigli / prenderti i bimbi 15 minuti)?”
E se ti sembra “troppo”, parti da una frase sola:
“Oggi sono giù. Ho bisogno di sostegno.”
Non stai chiedendo la luna. Stai facendo la cosa più adulta che esista: prenderti sul serio.
3 cose che peggiorano tutto (e che fanno male soprattutto alle mamme)
1) Il giudizio: “non dovrei sentirmi così”
È la frase che raddoppia il dolore. Perché alla tristezza aggiunge la colpa.
Se oggi puoi fare una sola cosa: smetti di trattarti come un problema.
Oppure se contini a farlo, chiediti con coraggio "A quale scopo mi tratto come se fossi problema?"
2) La modalità “sorriso di servizio” (e isolamento emotivo)
Non parlo dello stare sole ogni tanto (che a volte salva). Parlo di quel silenzio in cui continui a fare tutto, ma dentro ti chiudi.
La tristezza, quando non trova parole, spesso trova vie più dure: irritazione, durezza, stanchezza che esplode.
Anche qui serve l’essenziale: una persona affidabile, una frase vera, un contatto buono.
Piangi, santo cielo, PIANGI. Che lavi via tutto.
3) Anestetizzarti e rimuginare
Scroll infinito, cibo, lavoro compulsivo, serie in automatico… Non demonizzo: a volte è un tampone. Ma se diventa l’unico modo, la tristezza resta sotto e torna più pesante.
E il rimuginio è il fratello elegante dell’anestesia: sembra pensiero, ma spesso è solo una ruota che gira.
Un criterio semplice: se dopo 10 minuti di pensieri non nasce una azione di cura, non è riflessione. È loop.
Incazzati di brutto se serve, non fare finta di niente. Quando sei triste un motivo c'è sempre.
Se oggi ti porti via una cosa sola
La tristezza non è il contrario della felicità. È un passaggio umano.
Allenare la felicità, nella vita reale, significa questo: imparare a non perderti quando arriva, e scegliere un gesto semplice che ti riporti a te.
Seconda parte (che scriverò più avanti)
In un prossimo articolo entrerò nella tristezza dentro la vita di famiglia: cosa succede quando la tristezza è della mamma, del papà, della coppia… e come questo diventa educazione alla felicità familiare nella relazione educativa quotidiana.
Perché i bambini non imparano da genitori perfetti. Imparano da adulti che sanno fermarsi, respirare, chiedere aiuto, e riparare.
Con stima e affetto
Santina, allenatrice di felicità.
27/12/2025
Le domande degli occhi
Quando sei triste: 3 cose che aiutano davvero (e 3 che peggiorano tutto)
Quando sei triste: 3 cose che aiutano davvero (e 3 che peggiorano tutto)
Ci sono giorni in cui la tristezza entra in casa senza bussare.
Non sempre ha un motivo chiaro, non sempre si presenta con una scena drammatica. A volte è semplicemente una "nebbia" sulle cose: ti muovi, fai, rispondi… ma dentro senti che qualcosa è più lento, più pesante, più opaco.
E qui spesso scatta l’equivoco più comune: pensare che allenare la felicità significhi evitare la tristezza.
Io la vedo diversamente: non si può evitare la tristezza.
Allenare la felicità significa imparare una competenza di vita: restare presenti quando arrivano emozioni che non abbiamo scelto, e trasformare quel momento in un’occasione di ascolto e di direzione.
La tristezza è “l’altra faccia della medaglia” non perché sia il contrario della felicità, ma perché è una delle emozioni che ci ricordano che siamo umani, vulnerabili, attraversati da bisogni spesso ignorati e da aspettative sociali che non ci appartengono.
E se è vero che felici s’impara, è anche vero che si impara proprio lì: nel modo in cui stiamo dentro alle giornate storte, ed è complicato, e qualche volta anche tanto complicato.
La tristezza: non una nemica, ma un segnale (senza romanticismo)
Nella prospettiva del coaching umanistico e spirituale, io non parto dall’idea che le emozioni siano “problemi” da risolvere in fretta: le considero un linguaggio. Un modo con cui la vita interna prova a farsi capire prima ancora che noi abbiamo le parole giuste.
E qui vale una distinzione che chiarisce molto: emozioni e sentimenti non sono la stessa cosa.
Le emozioni sono risposte rapide e spesso corporee (un’onda): arrivano, attivano il corpo, orientano l’attenzione. Sono più immediate che razionali.
I sentimenti sono l’emozione “letta” e rielaborata dalla mente nel tempo: diventano una trama più stabile, fatta di pensieri, significati, memoria, interpretazioni e valori. In pratica: l’emozione è il segnale; il sentimento è il modo in cui quel segnale viene abitato e raccontato.
Per esempio: la tristezza come emozione può essere un impulso breve (una stretta al petto, un groppo in gola, un calo di energia). Se però a quella tristezza si agganciano frasi interiori ripetute (“non ce la farò”, “sono sola”, “non valgo”), allora può trasformarsi in un sentimento più duraturo: scoraggiamento, malinconia, amarezza, sfiducia.
Questa distinzione è importante tenerla ben presente perché ci fa vedere dove possiamo lavorare: non sempre possiamo impedire l’emozione, ma possiamo intervenire su ciò che ci costruiamo sopra (il racconto, le conclusioni, le scelte).
E allora la tristezza, come emozione, spesso segnala:
una perdita (non solo lutti: anche perdite apparentemente minori, delusioni, aspettative cadute)
un distacco (da una persona, da un progetto, da un’immagine di sé)
un bisogno rimandato troppo a lungo
un carico emotivo che stiamo portando da soli
un confine che non abbiamo saputo proteggere
Non sempre la tristezza ha un significato nitido e immediato: a volte si tratta di stanchezza, di stress accumulato, di un “troppo” che il corpo registra prima della mente.
Ma una cosa sì: la tristezza, quasi sempre, ci chiede rallentamento e ascolto.
Ed è qui che entra in gioco anche un principio Montessori (che vale benissimo per gli adulti): quando l’ambiente è sovraccarico, confuso, troppo pieno di stimoli e richieste, l’organismo tende a chiudersi. Per ritrovare equilibrio spesso non serve “spingere di più”, ma preparare un ambiente (interno ed esterno) che sostenga.
E qui mi torna in mente una frase attribuita ad Antoine de Saint‑Exupéry: “La perfezione si raggiunge non quando non c’è più niente da aggiungere, ma quando non vi è più niente da togliere.”
Impariamo ad alleggerire, alleggerire il nostro ambiente interno e anche quello esterno.
Un confine necessario: quando non basta “gestirla da soli”
Diciamolo senza giri: a volte la tristezza è un’onda che chiede ascolto. Altre volte è un segnale che chiede un aiuto più strutturato.
Il criterio che, più di tutti, fa chiarezza è il tempo. Ma non solo in senso numerico.
Una tristezza “normale” (per quanto scomoda) tende ad avere un andamento ondoso: arriva, sale, ti attraversa e poi lascia spazio a aperture. Non significa “stare bene”, significa che ogni tanto torna respiro: ti capita di concentrarti, di appoggiarti a qualcosa di semplice, di sentire che non sei solo quel nodo.
Quando invece la tristezza diventa un clima costante, il tempo cambia qualità: non è più qualcosa che va e viene, è una presenza che occupa le giornate e restringe lo spazio interno. Qui la domanda non è solo “da quanto dura”, ma come sta durando:
Ci sono (o no) finestre di sollievo?
Resta legata a momenti specifici o si allarga a tutto?
Ti lascia ancora la possibilità di fare un gesto di cura o spegne quasi ogni iniziativa?
Nel viaggio di conoscenza della tristezza questo passaggio è centrale: non giudichiamo l’emozione, ma osserviamo i suoi indicatori (intensità, frequenza, durata, impatto). È un’osservazione molto “Montessori per adulti”: guardare la realtà così com’è, senza etichette e senza drammatizzare, per capire quale percorso serve davvero.
E anche qui la CNV aiuta: invece di dirci “non dovrei stare così”, possiamo chiederci con onestà: che cosa sta succedendo nel mio quotidiano, da quanto, e quanto mi sta limitando?
Se la tristezza:
dura molte settimane senza aperture,
ti spegne quasi del tutto il piacere (anche delle cose che amavi),
ti blocca nel quotidiano delle tue giornate (cura di te, lavoro, relazioni),
si accompagna a autosvalutazione pesante,
o a pensieri di farti del male,
la scelta più matura è parlarne con un professionista della salute mentale (psicologo/psicoterapeuta/medico).
Qui è utile chiarire, con delicatezza ma con precisione, la differenza tra psicologia/psicoterapia e coaching.
La psicologia clinica (e la psicoterapia) si occupa di valutare e trattare la sofferenza psicologica quando diventa un disturbo, un blocco significativo o un rischio per la salute. Può fare una valutazione, lavorare su sintomi e cause, usare strumenti e metodi terapeutici, e — quando serve — integrarsi con il medico.
Il coaching non fa diagnosi e non tratta patologie: è un percorso di allenamento e sviluppo orientato a obiettivi, risorse, consapevolezza e azione. Lavora sul presente e sul futuro, sul modo in cui ti muovi nella vita, sulle scelte, sui punti di forza e sulle strategie per attraversare i momenti difficili senza perderti.
In pratica: quando la tristezza è intensa, persistente e ti spegne, la cornice clinica è spesso la più adeguata. Il coaching può comunque essere un sostegno prezioso in parallelo (o in una fase successiva), per ricostruire direzione, abitudini di cura, fiducia e passi concreti.
Questa non è “allarmismo”: è cura della realtà.
La tristezza ha sempre un motivo (anche quando non lo vedi)
Sì: anche quando ti sembra “senza motivo”, la tristezza un motivo ce l’ha. Solo che non sempre è immediato, non sempre è razionale, e spesso non è un evento unico e chiaro.
A volte il motivo è una perdita che hai minimizzato. A volte è un bisogno rimandato. A volte è un sovraccarico che hai normalizzato. A volte è un confine che non stai proteggendo. A volte è un tempo di vita che chiede di cambiare ritmo.
Quindi non è che la tristezza arrivi dal nulla: arriva quando qualcosa dentro di te sta dicendo “così non ce la faccio più come prima”.
E poi c’è una cosa ancora più vera: quando vivi una relazione di cura (e questo, spesso, significa essere mamma), la tristezza raramente si presenta come una cosa “tua e basta”.
Arriva mentre stai facendo altro. Arriva mentre qualcuno ti chiama. Arriva mentre devi comunque essere presente, e magari anche gentile.
E allora succede questo: ti dici che non puoi permettertela, la metti da parte, stringi i denti… e poi, a fine giornata, ti ritrovi più vuota.
Qui non ti propongo un elenco infinito. Ti propongo tre scelte che, quando sei triste, fanno davvero la differenza. Scelte concrete, realistiche, ripetibili. Scelte da vita quotidiana e concreta.
3 cose che aiutano davvero quando sei triste
1) Radicamento: tornare al corpo per sentirti sostenuta
Quando sei triste, la mente vuole spiegazioni. Il corpo, invece, chiede una cosa più semplice: sostegno.
E il sostegno comincia da qui: tornare al presente. Non serve il bosco. Non serve “fare bene”. Basta un minuto ovunque tu sia.
Radicamento rapido (60–90 secondi, ovunque):
Piedi: senti i piedi. Premi leggermente a terra.
Contatto: nota tre appoggi (piedi, schiena, mani…).
Sguardo: trova 5 cose che vedi e nominale mentalmente.
Respiro: espira un po’ più lungo per 5 volte.
Frase di presenza: “Sento la mia tristezza e la accolgo.”
Questo non “risolve” la tristezza. Ma spesso fa una cosa fondamentale: la rende sostenibile.
Ti suggerisco un nuovo approccio, ispirato anche al LoveHealing (la pratica di guarigione interiore che ho studiato con Lucia Merico nel percorso di formazione come Spiritual Coach®): affidare con amore ciò che stai vivendo — non come rinuncia, ma come atto di fiducia consapevole nella guarigione e speranza nel futuro.
In concreto: porti la situazione nel cuore, formuli un intento chiaro (cosa desideri guarire o comprendere), dai una direzione (il passo che scegli di fare), e poi la affidi all’Universo con la certezza interiore di ricevere guida e sostegno nel processo.
E mentre affidi, resti con i piedi per terra: respiri, ti radichi, e fai il tuo passo possibile — perché spiritualità e responsabilità, qui, camminano insieme.
2) Preparare l’ambiente: Montessori per adulti (e sopratutto per le mamme)
Quando sei triste, spesso non hai bisogno di “motivarti”. Hai bisogno di ridurre il troppo.
È un principio Montessori che vale anche per noi grandi: quando l’ambiente è sovraccarico, il sistema si chiude. E allora la cura può essere sorprendentemente concreta.
Scegli una sola azione essenziale che rimetta ordine e ossigeno:
aprire la finestra e cambiare aria
bere un bicchiere d’acqua e sederti 30 secondi
doccia tiepida (anche veloce)
riordinare un angolo (uno)
Non è “positività”. È igiene emotiva. È dire al tuo corpo: qui c’è spazio per me, anche oggi.
3) Dire cosa ti serve (senza sentirti egoista): CNV in versione mamma
Molte mamme soffrono in silenzio perché pensano che chiedere sia un peso. E così diventano brave a resistere… ma non a farsi sentire e sostenere.
La CNV, nella sua essenza, è questo: trasformare un nodo in una richiesta pulita.
Formula breve:
“In questo momento mi sento… (triste / fragile / stanca).”
“Ho bisogno di… (silenzio / vicinanza / 10 minuti da sola / un abbraccio).”
“Puoi… (occuparti tu di… / ascoltarmi senza consigli / prenderti i bimbi 15 minuti)?”
E se ti sembra “troppo”, parti da una frase sola:
“Oggi sono giù. Ho bisogno di sostegno.”
Non stai chiedendo la luna. Stai facendo la cosa più adulta che esista: prenderti sul serio.
3 cose che peggiorano tutto (e che fanno male soprattutto alle mamme)
1) Il giudizio: “non dovrei sentirmi così”
È la frase che raddoppia il dolore. Perché alla tristezza aggiunge la colpa.
Se oggi puoi fare una sola cosa: smetti di trattarti come un problema.
Oppure se contini a farlo, chiediti con coraggio "A quale scopo mi tratto come se fossi problema?"
2) La modalità “sorriso di servizio” (e isolamento emotivo)
Non parlo dello stare sole ogni tanto (che a volte salva). Parlo di quel silenzio in cui continui a fare tutto, ma dentro ti chiudi.
La tristezza, quando non trova parole, spesso trova vie più dure: irritazione, durezza, stanchezza che esplode.
Anche qui serve l’essenziale: una persona affidabile, una frase vera, un contatto buono.
Piangi, santo cielo, PIANGI. Che lavi via tutto.
3) Anestetizzarti e rimuginare
Scroll infinito, cibo, lavoro compulsivo, serie in automatico… Non demonizzo: a volte è un tampone. Ma se diventa l’unico modo, la tristezza resta sotto e torna più pesante.
E il rimuginio è il fratello elegante dell’anestesia: sembra pensiero, ma spesso è solo una ruota che gira.
Un criterio semplice: se dopo 10 minuti di pensieri non nasce una azione di cura, non è riflessione. È loop.
Incazzati di brutto se serve, non fare finta di niente. Quando sei triste un motivo c'è sempre.
Se oggi ti porti via una cosa sola
La tristezza non è il contrario della felicità. È un passaggio umano.
Allenare la felicità, nella vita reale, significa questo: imparare a non perderti quando arriva, e scegliere un gesto semplice che ti riporti a te.
Seconda parte (che scriverò più avanti)
In un prossimo articolo entrerò nella tristezza dentro la vita di famiglia: cosa succede quando la tristezza è della mamma, del papà, della coppia… e come questo diventa educazione alla felicità familiare nella relazione educativa quotidiana.
Perché i bambini non imparano da genitori perfetti. Imparano da adulti che sanno fermarsi, respirare, chiedere aiuto, e riparare.
Con stima e affetto
Santina, allenatrice di felicità.
20/12/2025
Artigiani di felicità
Allenare la felicità: trovare il proprio modo
Allenare la felicità: trovare il proprio modo
Introduzione
Il Natale e il nuovo anno arrivano sempre con una promessa implicita: “Da gennaio cambierà tutto”. Cambieremo noi. Le abitudini. L’energia. La direzione.
Eppure, paradossalmente, proprio il periodo che dovrebbe accompagnarci verso il riposo e il rallentamento diventa spesso una fonte di ulteriore stanchezza. Le vacanze si riempiono di impegni, aspettative, pranzi da organizzare, relazioni da gestire, valigie da preparare, agende da incastrare. Si corre anche quando si dovrebbe sostare.
Arriviamo a gennaio non più riposati, ma semplicemente scarichi. E da quella stanchezza chiediamo a noi stessi di cambiare tutto: di essere più puntuali, più magri, più performanti; di andare finalmente in palestra, di imparare a parlare inglese, di diventare la versione “migliore” di noi stessi nel minor tempo possibile.
Dove comincia l’autoinganno
È qui che nasce la frattura: non solo pretendiamo trasformazioni profonde da un corpo e da una mente che non hanno avuto il tempo di fermarsi davvero, ma iniziamo anche a raccontarci la classica storia dell’orso. Ci fissiamo obiettivi altisonanti, vaghi, quasi fantastici, frutto più di aspettative irrealistiche che di un reale ascolto di noi stessi. Obiettivi così lontani e illusori da permetterci, inconsciamente, di non metterli mai davvero a terra, accumulando poi tutte le scuse possibili per giustificare il fatto di non aver fatto ciò che ci eravamo detti.
Ed è proprio lì che, puntuale come le lucine sull’albero, compare la lista dei buoni propositi: fare di più, fare meglio, sistemare ciò che “non va”. Succede spesso nei momenti di stanchezza, magari la sera, sul divano, con la sensazione di dover recuperare terreno. Si scrive una lista veloce, mentale o su un foglio, senza partire da come stiamo davvero, ma da come pensiamo di dover essere. Più che uno strumento di orientamento, quella lista diventa così una risposta automatica al clima del periodo, lontana dall’ascolto autentico di sé e dalla realtà concreta della propria vita.
Poi le vacanze finiscono, rientriamo al lavoro, passa qualche settimana – a volte bastano pochi giorni – e quella spinta iniziale si affloscia. Subentrano confusione, indecisione, una “non voglia” che non è pigrizia ma disorientamento.
E spesso ci facciamo pure del male da soli: ci sentiamo sbagliati, incoerenti, incapaci di portare avanti ciò che abbiamo deciso. Arriva il senso di colpa e quella voce interiore che sussurra “è colpa mia”. È colpa mia se non sono abbastanza puntuale. È colpa mia se non riesco a fare quello che mi ero promessa. È il copione classico di quando mancano strumenti, metodo e accompagnamento, e l’unica spiegazione che ci diamo è che il problema siamo noi.
E qui voglio essere chiara: non è (quasi) mai un problema di volontà. È che stiamo provando a cambiare senza una struttura che ci accompagni, e allora l’automatismo vince facile. Per questo esiste il metodo Felici s’impara: per rendere il cambiamento concreto, sostenibile e finalmente nostro. Non per controllarci di più, ma per capirci meglio. Non per sacrificarci, ma per trovare un equilibrio vero tra corpo, mente e cuore.
In questo articolo ti porto dentro tre passaggi semplici ma profondi: fermarti davvero e osservarti senza giudizio, dare un nome alle paure cercando il senso, e ripartire dai tuoi punti di forza per costruire il tuo modo di cambiare. Perché i buoni propositi, da soli, non bastano. La felicità si allena.
I buoni propositi, da soli e senza un metodo, non funzionano
Perché senza un metodo non si va da nessuna parte
I buoni propositi, presi da soli, sono intenzioni. E le intenzioni, se pur molto potenti, a volte; se non sono sostenute da un metodo, restano fragili e non permettono un vero e proprio cambiamento.
Senza un metodo accadono sempre le stesse cose:
- si parte sull’onda dell’entusiasmo senza pianificare nulla
- si salta l’osservazione di sé
- si confonde l'esagerare con il cambiare
- si interpreta la fatica come fallimento personale
Un metodo, invece, non serve a controllarsi di più, ma a capirsi meglio. Serve a leggere i segnali di stanchezza, di resistenza, di confusione non come nemici, ma come informazioni preziose. Certo che nel cambiamento ci stanno la fatica, la determinazione, la volontà: fanno parte del cammino. Quello che non funziona – e non funzionerà mai – è l’idea di sacrificio intesa come rinuncia alla felicità, come “stringere i denti oggi” sperando di stare bene domani. La felicità non è qualcosa da mettere in pausa per diventare persone migliori: ha a che fare con il piacere di ciò che facciamo, con ciò che nutre, sostiene e dà gusto alla vita mentre camminiamo, non alla fine del percorso.
Felici s’impara è un metodo educativo e di coaching che integra osservazione, ricerca di senso e allenamento dei punti di forza. Non promette cambiamenti rapidi, dall'oggi al domani, che a volte avvengono davvero, ma cambiamenti possibili, sostenibili e veri.
Solo quando esiste una struttura che accompagna, il cambiamento smette di essere un peso e diventa un cammino.
Fermarsi davvero: l’osservazione silenziosa (ispirazione Montessori)
Quando arriva l’apatia, quel senso di “non ho voglia di” che spesso dimettiamo in fretta come pigrizia o mancanza di carattere, il riflesso automatico è uno solo: spingerci.
“Dai, muoviti.”
“Devi solo iniziare.”
“È questione di disciplina.”
Ma l’apatia, molto spesso, non è assenza di volontà. È un segnale di sovraccarico. È il modo che il corpo e la mente hanno per dire: così no. Non è che non abbiamo voglia di fare nulla; è che non abbiamo più energia per fare cose che non sentiamo allineate, sensate, abitabili. L’apatia arriva quando abbiamo dato troppo, ascoltato poco e continuato a chiedere prestazioni anche nei momenti in cui sarebbe stato necessario fermarsi e ricalibrare.
Ma se quella stanchezza non fosse pigrizia? Se fosse invece un segnale chiaro che stai correndo verso qualcosa che non ti appartiene?
Maria Montessori ci ha insegnato una cosa fondamentale: l’osservazione non è passività, è presenza profonda. Osservare significa sospendere il giudizio e ascoltare davvero.
Sospendere il giudizio non significa non avere opinioni o punti di vista. Significa non trasformare subito ciò che osserviamo in una sentenza su di noi o sugli altri. Il giudizio chiude, etichetta, blocca: “sono fatta così”, “non ce la farò mai”, “sbaglio sempre”. Dare un’opinione, invece, è un atto diverso, più morbido e più onesto: descrive ciò che vedo in questo momento, senza decidere chi sono o chi sarò. Nell’osservazione autentica non mi condanno e non mi assolvo: mi ascolto. Ed è solo da questo ascolto, non dal giudizio, che può nascere un cambiamento reale.
Un esercizio semplice, reale
Durante le feste – a tavola, in un momento di calma – prova a:
accogliere i tuoi pensieri così come arrivano
osservare la tua indecisione senza etichettarla
restare qualche istante con ciò che senti, senza dover subito risolvere
Domande guida:
Cosa sento quando penso a gennaio?
Quali impegni mi tolgono energia ancora prima di iniziare?
Dove sento resistenza nel corpo?
Dare un nome alle paure e cercare il senso
Dietro l’indecisione, quasi sempre, c’è una paura. A volte ben nascosta: paura di fallire, di non essere costanti, di riuscirci davvero. Paure che raramente riconosciamo come tali, perché spesso si presentano sotto forma di blocco, di rimando, di confusione. Nel lavoro di coaching questo è un passaggio chiave: imparare a stare con la paura senza combatterla.
Con le tecniche di * Lovehealing* non si lavora contro la paura, ma con la paura. La si accoglie, la si ascolta, la si attraversa con gentilezza. Perché ogni paura custodisce un bisogno non visto, una parte di noi che chiede attenzione e cura, non giudizio.
Qui entra in gioco anche il lavoro sulla nostra ombra. L’ombra non è ciò che è sbagliato in noi, ma ciò che abbiamo imparato a nascondere perché non era accettato, riconosciuto o valorizzato. Quando un obiettivo tocca una parte d’ombra – per esempio il timore di non essere abbastanza, di esporsi, di cambiare davvero – l’energia si blocca. Non per debolezza, ma per protezione.
Leggere l’ombra significa portare luce dove prima c’era silenzio. Significa smettere di chiedersi solo “cosa devo fare?” e iniziare a domandarsi “quale parte di me ha paura, e di cosa ha bisogno ora?”. È da questo incontro, non dalla forzatura, che può nascere un cambiamento che abbia senso e radici profonde.
La domanda da porsi non è: “Cosa devo fare?” ma “A quale scopo lo voglio fare?”
Se un obiettivo nasce per sentirsi all’altezza, per non deludere, per rispondere a uno standard esterno o a un’immagine ideale di come dovremmo essere, l’energia dura poco. All’inizio può esserci entusiasmo, persino motivazione, ma è un’energia che si brucia il fretta come i colpi di fulmine, fragile, che si consuma veloce perché non è radicata nella persona, non ci sono fondamenta di valore, ma sono radicate solo nel giudizio – reale o immaginato – degli altri.
Quando invece un obiettivo nasce dal senso e dal significato concreto e quotidiano del nostro vivere, tutto cambia. Nasce da una domanda più profonda: perché questo è importante per me? Che valore ha nella mia vita? Che tipo di persona mi permette di diventare, senza tradirmi? Un obiettivo che nasce dal senso non ha bisogno di essere spinto ogni giorno con la forza: trova nutrimento nella coerenza, nel significato, nel piacere di sentire che ciò che faccio mi assomiglia, mi dà gioia e gratificazione. Ed è proprio da qui che il cambiamento smette di essere una lotta e diventa un cammino possibile.
Un esempio natalizio
Pensa ai regali: li facciamo per abitudine, per dovere, per non scontentare qualcuno, oppure per un desiderio autentico di creare connessione? Esteriormente l’azione è la stessa: compriamo, incartiamo, consegniamo. Ma interiormente cambia tutto. Quando il gesto nasce dall’obbligo, pesa, stanca, spesso irrita. Quando invece nasce dal desiderio di far sentire l’altro visto, riconosciuto, amato, quello stesso gesto diventa nutriente, persino rigenerante.
Succede esattamente la stessa cosa con i nostri obiettivi. Possiamo “fare la cosa giusta” per dovere, per paura di sbagliare o di deludere, oppure possiamo farla perché è allineata a ciò che conta davvero per noi. Il comportamento può sembrare identico dall’esterno, ma l’energia con cui lo viviamo cambia radicalmente. Ed è proprio questa differenza di senso che determina se un impegno diventerà un peso da abbandonare o un cammino che riusciamo a sostenere nel tempo.
La tanto citata legge dell’attrazione può essere letta anche così: non otteniamo ciò che desideriamo, ma ciò che siamo pronti a incarnare. A livello profondo, ciò che coltiviamo dentro di noi prende forma anche fuori. Se il nostro “dentro” è povero di vitalità autentica e sostenuto solo da una finta esuberanza o da buone intenzioni non radicate, il “fuori” non potrà che rimandarci la stessa qualità. Il cambiamento reale inizia quando smettiamo di voler attrarre qualcosa e iniziamo a prenderci cura di ciò che abita dentro di noi.
Ripartire dai punti di forza
La maggior parte dei buoni propositi nasce da una mancanza percepita. Partiamo da ciò che crediamo di non avere, di non essere, di dover correggere. Ma è proprio questo sguardo che genera malessere. L’autorealizzazione e l’autogoverno personale non nascono dal tentativo continuo di aggiustarsi, ma dal riconoscimento consapevole di ciò che già vive in noi come potenzialità. Conoscere i propri punti di forza significa sapere da dove partire, come orientarsi, come governare le proprie energie senza disperderle. È nel disconoscimento dei nostri punti di forza che spesso nasce il malessere: quando cerchiamo di essere ciò che non siamo, o di crescere secondo modelli che non ci appartengono. Non ricordo chi lo scrisse, ma ricordo bene le parole e il senso: se siamo un pino non diventeremo mai una quercia, ma possiamo diventare il più bel pino del bosco. E questo vale anche per noi che piante non siamo: non si tratta di cambiare natura, ma di fiorire pienamente nella propria.
Ecco cosa significa, per parti alcuni esempi, nella pratica, ripartire dai punti di forza:
se voglio mantenermi in forma ma so che la palestra non fa per me, perché gli spazi chiusi mi spengono e non mi piacciono, smetto di forzarmi. E scelgo quello che mi viene naturale: camminare di buon passo ogni giorno, all’aria aperta, magari nel bosco. In questo caso il mio punto di forza non è la palestra, e nemmeno il culto del corpo. Il punto di forza è trovare un equilibrio tra corpo, mente e cuore. È questo valore che mi sostiene e mi motiva a prendermi cura di me ogni giorno, rendendo possibile e naturale l’impegno della camminata quotidiana nella natura.
se desidero essere più calma e paziente, ma mi accorgo che impormi tecniche rigide o momenti di meditazione “perfetti” mi crea solo altra pressione, posso partire da ciò che già mi aiuta davvero. Per esempio: mettere ordine, fare una cosa alla volta, ritagliarmi dieci minuti di silenzio mentre sistemo casa. Qui il mio punto di forza non è la disciplina impeccabile, ma la capacità di ritrovare serenità attraverso gesti semplici e concreti.
se desidero sentirmi più realizzata nel lavoro, ma obiettivi rigidi e scadenze serrate mi mettono ansia, non devo per forza adattarmi a quel modello. Posso cercare il mio modo di lavorare: seguire una cosa alla volta, curare bene le relazioni, portare avanti i progetti con attenzione e presenza. In questo caso il mio punto di forza non è correre di più, ma trovare un modo di lavorare che mi assomigli e che mi permetta di stare bene mentre faccio ciò che faccio.
Questo cambio di sguardo alleggerisce subito il cammino, perché non parte dalla correzione di sé, ma dal riconoscimento delle proprie risorse.
Felici s’impara ribalta la prospettiva: parte dai punti di forza. Quando una persona utilizza ciò che già funziona in lei, l’azione diventa sostenibile.
Trovare il proprio modo
Se c’è un filo che tiene insieme tutto ciò che abbiamo attraversato, è questo: non serve diventare qualcun altro per stare meglio. Serve trovare il proprio modo.
I buoni propositi falliscono non perché siamo incapaci o poco determinati, ma perché spesso nascono da aspettative esterne, da modelli che non ci somigliano, da un’idea di cambiamento fatta di sacrificio e prestazione. Quando invece impariamo a fermarci, ad ascoltarci, a dare un nome alle paure e a ripartire dai nostri punti di forza, il cambiamento smette di essere una lotta.
Con Felici s’impara non si tratta di fare di più, ma di fare in modo più vero. Di scegliere strade abitabili, che tengano insieme corpo, mente e cuore. Di allenare la felicità non come meta lontana, ma come criterio quotidiano delle nostre scelte.
Un nuovo anno, allora, non è l’occasione per rifarsi da capo, ma per tornare a sé. Per smettere di rincorrere ideali irraggiungibili e iniziare a camminare – ciascuno a modo suo – nella direzione che gli assomiglia davvero.
25/11/2025
Artigiani di felicità
Augurandovi un Magico Natale 2025
Un allenamento quotidiano per la Tua Vita felice e in salute: il collegamento indissolubile tra Salute, Felicità e il cambiamento.
A cura di Santina Bossini, Allenatrice di Felicità, ed Elena Cherubini, Coach Riflessologa ed Esperta di Medicina Cinese.
Siamo liete di presentarvi il nostro progetto: il Calendario dell’Avvento dell’Autenticità, un percorso unico che fonde la pragmaticità del Coaching Umanistico con la saggezza olistica della Medicina Tradizionale Cinese (MTC).
La felicità non è una meta lontana o una benedizione casuale; è una vera e propria abilità che si può imparare e allenare. Proprio come un muscolo, se non allenata, si atrofizza, ma con la pratica costante, cambia la nostra "postura della vita".
Il Vostro Benessere: Un’Unica Manifestazione di Energia (Qi)
Per troppo tempo abbiamo diviso il corpo dalla mente e dalle emozioni. La Medicina Tradizionale Cinese ci insegna, invece, che mente, corpo ed emozioni sono un'unica manifestazione del Qi (energia vitale). Non c'è distinzione tra psiche e soma: entrambi sono espressione della medesima realtà.
In questa visione olistica, la salute (e quindi la vera felicità) è sinonimo di Equilibrio. Quando il Qi fluisce liberamente, siamo in armonia (omeostasi); quando quest'energia si blocca, o è in disequilibrio, compaiono malesseri e malattie.
Un Esempio Quotidiano di Blocco Energetico: Pensate a quando siete sopraffatte dall’ossessività o dalla preoccupazione. Questo stato fa male all'energia della Milza-Pancreas (Elemento Terra). I sintomi non sono solo mentali; possono manifestarsi con stanchezza, senso di pesantezza, pancia gonfia, o la testa "annebbiata". Il nostro calendario unisce questi due mondi, mostrando come un'azione mirata (fisica o mentale) influenzi l'intero sistema.
L’Allenamento al Cambiamento: La Volontà che Diventa Azione
Il cambiamento non avviene solo "volendo". La volontà è un inizio, ma senza un allenamento concreto e quotidiano si esaurisce. Per noi, il coaching è l'Allenamento della Felicità e delle potenzialità.
Il nucleo del nostro approccio è il concetto di Darsi Da Fare (DDF) intenzionale. Non si tratta di sforzo frenetico, ma di piccole scelte quotidiane, coerenti e consapevoli. È la disciplina come forma di libertà, che nasce dal desiderio profondo di scegliere ciò che ci fa bene e ci rende autentiche.
Il desiderio di cambiare parte dalla Volontà, la radice della vita. In MTC, questa spinta esistenziale risiede nell'Elemento Acqua (Reni). Se non decidiamo dove vogliamo andare, la nostra energia potenziale resta inutilizzata. Allenarsi alla felicità significa attivare proprio questa spinta interiore, trasformando il sogno in un percorso fatto di piccoli passi.
Il Calendario: 24 Giorni di Micro-Azioni Consapevoli
Il "Calendario dell'Avvento della Salute e della Felicità" è concepito come una vera e propria palestra di crescita personale. Per 24 giorni, vi offriamo uno strumento per l'allenamento quotidiano.
Ogni giorno è dedicato all'attivazione di una specifica Potenzialità del Carattere (come la Gratitudine, il Coraggio o la Perseveranza), correlata a un Organo MTC e alla sua funzione energetica. Riceverete tre elementi di pratica:
L’Ispirazione (Potenzialità): Il punto di forza da allenare quel giorno (es. Perseveranza).
L'Allenamento (Pratica DDF): Un compito specifico.
Il Corpo (MTC): Un'azione fisica collegata all'Organo.
Esempi Concreti di Allenamento Corpo-Mente:
Allenare la Gratitudine (Elemento Metallo/Polmoni):
La Gratitudine non è solo un sentimento, ma una potenzialità che modifica la chimica del nostro corpo, producendo oppioidi e ossitocina (il neuropeptide della fiducia e della connessione).
Il DDF intenzionale è scrivere almeno tre cose per cui si è grati. Questo allenamento costante induce modifiche neurologiche stabili nel cervello, ampliando il senso di benessere.
Allenare il Coraggio (Elemento Legno/Cistifellea):
Il coraggio è necessario per agire nonostante la paura. La Cistifellea in MTC è correlata alla capacità di prendere decisioni e bilanciare l'indecisione.
Il DDF legato al Corpo può essere l'esecuzione di allungamenti laterali utili per sbloccare il meridiano e rilassare le spalle, spesso irrigidite dalla rabbia o dalla frustrazione.
Attraverso i Cinque Movimenti della MTC (Acqua, Legno, Fuoco, Terra, Metallo), il calendario vi guida ciclicamente per assicurare che corpo, mente e spirito lavorino insieme, passo dopo passo, verso il vostro massimo potenziale.
Vi invitiamo a non limitarvi alla teoria, ma ad agire concretamente. Questo allenamento consapevole è il primo atto di cura verso sé stessi, l'occasione per risvegliare la vostra parte autentica che aspetta solo di essere vissuta.
Non devi inventarti. Devi solo ricordarti chi sei.. Inizia oggi il tuo Darsi Da Fare per la tua salute e felicità.
Con stima e gratitudine, Santina Bossini e Elena Cherubini.


